Speciale Biografilm 2025 - dietro le quinte del festival che celebra le vite.
Conclusa la ventunesima edizione di Biografilm aspettando la prossima.
Cosa ci ha lasciato il festival che celebra le vite - Speciale dietro le quinte
___
a cura di Matilde Sirianni
Un mese fa, il Biografilm Festival accendeva Bologna con la sua selezione di film, ospiti e incontri: dieci giorni intensi che hanno celebrato il cinema del reale in tutte le sue forme. Ma cosa rimane, oggi, di quella esperienza? Tramite alcune voci dal “dietro le quinte” percorriamo qui il filo rosso che lega registi, attori e produttori presenti al festival — il desiderio di raccontare la realtà con coraggio e immaginazione.
⸻
L’edizione 2025 si è conclusa con oltre quattordicimila presenze di pubblico, più di 1.700 accreditati e ben 9 proiezioni sold out, segnali
concreti di una comunità che risponde partecipe. Le proiezioni hanno animato spazi simbolici della città – dal Cinema Lumière fino al nuovo ingresso del Cinema Modernissimo – per un totale di 9.244 biglietti emessi. Oltre 50 realtà del territorio – tra associazioni, fondazioni e collettivi – hanno contribuito ad amplificare l’impatto dei film e la profondità dei temi trattati. Momenti di riflessione e dialogo si sono alternati a eventi di rilievo internazionale, come la masterclass molto partecipata di Tom Quinn, CEO di Neon, tra i distributori indipendenti più influenti del panorama statunitense.
Tom Quinn - CEO Neon
“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati del Festival di quest’anno, che mostrano una sensibile crescita di attenzione da parte del pubblico, della stampa e degli addetti ai lavori. Biografilm continua la sua strada di ricerca sul documentario e sul cinema contemporaneo, una formula vincente pronta ad accogliere ogni anno nuove sfide. Siamo già al lavoro per l’edizione del 2026, felici di proseguire il nostro dialogo all’interno della comunità di Biografilm”.
Chiara Liberti e Massimo Benvegnù, direzione artistica Biografilm
Il futuro è già scritto? — Orwell 2+2=5 di Raoul Peck
Il 7 giugno Raoul Peck ha presentato in anteprima italiana, Orwell 2+2=5 inaugurando la 21esima edizione di Biografilm. Il regista ed ex ministro della cultura di Haiti, noto per I Am Not Your Negro, con questa sua ultima opera riflette sul potere della narrazione e sulla manipolazione della verità, rileggendo 1984 come un un prisma attraverso cui osservare il presente — tra propaganda, verità distorte e memoria collettiva.
In un’intervista intensa, Peck ci racconta come il progetto sia nato quasi “per caso”, sapeva di voler fare qualcosa con Orwell, ma la Universal deteneva tutti i diritti sulle sue opere. Non c’era un piano preciso, è cominciato tutto da una telefonata col produttore e amico Alex Gibney.
.. sapevo di avere accesso a tutto —continua Peck— avevo una sola pagina scritta e tre settimane dopo il film era finanziato. Il resto è stato una corsa contro il tempo e contro la realtà stessa.
Il tono asciutto ma appassionato, quasi militante, rivela la funzione politica del racconto che Peck ci racconta dietro le quinte del festival.
“La maggior parte dei miei film sono molto concettuali, ho una mia idea del mondo, di come funziona. La mia esperienza di vita mi ha permesso di avere molti punti di vista diversi: sono cresciuto ad Haiti, ma anche in Congo, negli Stati Uniti, in Germania, in Francia. Sono cresciuto assorbendo tutti questi modi diversi di vedere il mondo, anche imparando a capire come pensano gli altri. Sono stato formato da una generazione che era fondamentalmente in rivolta – erano gli anni ’70 a Berlino, tutti i movimenti di liberazione erano presenti.
Raoul Peck x Biografilm 2025
Io sono arrivato al cinema attraverso la politica, non perché volessi raccontare storie o crearmi un piccolo mondo creativo da artista. No, per me il cinema è sempre stato uno strumento incredibile per raggiungere le persone, per provare a cambiare le cose. Non credo che un film possa cambiare il mondo da solo, ma è essenziale, come strumento culturale, per contribuire al cambiamento.
Orwell 2+2=5 — “Viviamo già dentro la distopia”
Peck parla anche del modo in cui lavora sul materiale d’archivio, non per nostalgia, ma per far parlare la Storia contro se stessa.
“La mia prima esigenza è stata riscoprire Orwell. Chi è davvero? Cosa dice del mondo? Rileggendo il suo saggio “Why I Write” – è diventato subito la pietra angolare del film. Era importante trovare una storia. Perché io non faccio biografie (anche se qui può sembrare). Creo una narrazione, una storia che si possa vedere più volte. Se fai solo un documentario, come quelli della CNN o un’inchiesta classica, lo guardi una volta e finisce lì. Ma io ho bisogno di una storia. E una storia significa personaggi, motivazioni, conflitti. Con Orwell era chiaro: doveva trattarsi degli ultimi anni della sua vita. Mentre lotta per finire 1984, è molto malato, la sua vita privata è a pezzi: ha perso sua moglie, ha un figlio piccolo di cinque anni... Tutti gli ingredienti di una vera situazione drammatica erano lì, anche se sappiamo che 1984 esiste, nel film non sappiamo davvero se ce la farà a terminarlo. Questo mi ha dato una struttura narrativa.
La potenza visiva di Orwell 2+2=5 cela una visione radicale del cinema come strumento di lotta, nella convinzione che il cinema debba restituire complessità, non limitarsi a “informare” come un semplice reportage.
Il film affronta anche il ruolo dei media e la normalizzazione della sorveglianza.
“Le persone usano spesso il termine “distopia” per 1984. Io non credo che lo sia. Lui analizzava il mondo che vedeva, that’s why the film is so real!
Non è un’invenzione, né una profezia, scriveva quello che vedeva del mondo, ed è accurato. Era sempre tormentato anche dalla sua condizione di scrittore. Molto critico verso gli altri scrittori, e verso se stesso. Cercava sempre qualcosa di reale. Già a 18 anni, andando in Birmania, capì di stare dalla parte sbagliata. Era complice della colonizzazione, e ne provava vergogna. Ha scoperto “l’altro”, ha capito che non c’è solo l’Inghilterra al centro del mondo. E ha cercato, da lì in poi, di essere la persona migliore possibile. Il miglior scrittore, il miglior essere umano che potesse essere. Senza paura di contraddirsi, senza paura di prendere decisioni difficili, anche impopolari. He wanted to be truthful to himself, per questo è stato accusato di tradimento anche dalla sinistra, dal Partito Laburista, dai comunisti. Ma lui non tollerava gli abusi, neanche da parte di chi stava teoricamente dalla sua parte.
Cosa c’entrano Trump e Elon Musk?
“Io non ho inserito Trump o Musk – si sono inseriti da soli, è questa la realtà. La distrazione quotidiana. Ogni giorno c’è qualcosa che attira l’attenzione della stampa, mentre nel frattempo il sistema erode tutte le istituzioni. I can’t breathe vuol dire questo, sei bombardato da così tante sciocchezze che non riesci più a pensare in modo lucido.
Orwell non prevedeva il futuro, ma vedeva il pericolo. E noi continuiamo a non fare molto. Perché? È la natura umana? No. È un sistema che ha delle conseguenze sulle nostre vite, sulle nostre scelte, sulla nostra sopravvivenza. Immaginiamo la democrazia come qualcosa che c’è, ma non è una cosa che si conquista una volta per tutte. Va difesa ogni giorno. Quando non agisci, il bullo continua. Un passo alla volta. Poi, quando te ne rendi conto è troppo tardi... sei solo. Gli altri sono già stati messi da parte. Per questo finisco il film dicendo: “tutto è già stato scritto”. Anche in Exterminate All the Brutes, lo dico: gli intellettuali, i filosofi, gli scrittori hanno già detto tutto. Non c’è nulla da inventare: sappiamo come funziona la società, la democrazia, la dittatura. Ma non riconosciamo i segnali. We already know the truth we just don't want to act upon it.
Ma c’è ancora una speranza?
“È una domanda che pongo anche allo spettatore. La speranza nasce nel momento in cui voi – ognuno di voi – decide, individualmente o collettivamente. Non c’è niente che cade dal cielo. La storia è fatta dagli esseri umani. Ogni individuo deve chiedersi: “sono parte del problema o della soluzione?” Sono decisioni, individuali o collettive, non c'è la magia.
E aggiunge, con una calma spiazzante:
“Io non ho una soluzione, posso solo offrire informazioni, collegamenti, storia. È quello che cerco di fare con i miei film: mostrare il quadro più ampio, come tutto è collegato. Pensiamo che il nostro piccolo mondo sia il centro. Ma è il contrario. Solo parlando, leggendo, guardando film possiamo iniziare a capire e – forse – a prendere decisioni. Ma non c’è una ricetta.
Che futuro vedi per il cinema indipendente?
Bisogna lottare per avere uno spazio. Io lo sapevo fin dall’inizio: il 90% dell’industria cinematografica è centro-destra, anche se finge di non esserlo. È tutta una questione di soldi.
Per questo sono sempre stato anche produttore: non perché mi piacesse, ma per avere indipendenza. E ho lasciato il cinema più volte nella mia vita, quando pensavo ci fossero cose più importanti da fare. Per me, ogni film è una scelta a sé. Non faccio film come se fossero qualcosa per cui dare la vita. A volte non ha senso farli.
E sì, abbiamo perso molte battaglie. Non so cosa accadrà. Anche l’idea stessa di “cinema” è in discussione. Per la prima volta nella storia, le piattaforme – come le chiamiamo ora – non prevedono più il cinema in sala nel loro piano industriale. Non gliene importa niente se un film viene proiettato o no: è solo un prodotto in mezzo a tanti. È la prima volta che succede, da quando esiste il cinema.
Joshua Oppenheumer — The End è un musical sull’estinzione
Dopo aver scioccato il mondo con The Act of Killing, Joshua Oppenheimer torna a Biografilm con un film che rompe ogni schema: The End è una favola nera, un musical post-apocalittico, un incubo familiare e metafisico. Al suo fianco, l’attore George MacKay (noto per 1917 e Captain Fantastic) ha raccontato l’esperienza sul set: “Non c’erano prove classiche, solo un lavoro emotivo profondo con Joshua. Voleva che disimparassimo a recitare.”
“Ci stiamo rifugiando nei nostri bunker — metaforici e reali — costruiti di social media, di narcisismo amplificato e paura. Sappiamo che la nostra civiltà collasserà. Solo trasformando radicalmente il modo in cui viviamo insieme su questa terra potremo sopravvivere. “Apocalisse”, etimologicamente, significa “rivelazione”. E noi siamo i primi esseri umani a vivere dopo quella rivelazione. Abbiamo già scoperto come finirà. Stiamo già vivendo nel post-apocalisse. E allora la vera domanda che il film pone è: come cambiare? Come perdonarci? Come trovare la compassione per farlo prima che sia troppo tardi?
Oppenheimer ha definito il film “un’esplorazione della nostra incapacità di immaginare il futuro”. Un’opera radicale che sfida lo spettatore a fare i conti con il collasso — climatico, sociale, personale — in atto.
Il musical come maschera della disperazione
Il musical è il genere ideale per rappresentare un tipo specifico di illusione collettiva: quella
dell’ottimismo senza basi, del “andrà tutto bene” anche quando stiamo andando a sbattere. Il
musical canta “il sole sorgerà domani”, mentre corriamo verso la catastrofe.
Ma questo non è speranza, è disperazione travestita da speranza. È il Lupo della
Disperazione con il mantello della melodia.
Nei musical, i personaggi cominciano a cantare nel momento di crisi: quando le loro razionalizzazioni non reggono più, quando il castello di illusioni vacilla. E allora cercano disperatamente nuove scuse per continuare come prima. Cercano di convincersi che tutto andrà bene, che le loro scelte passate erano giuste. È un meccanismo di negazione, non di verità.
Nel mio film, queste canzoni sono crolli emotivi estremi, perciò tutto il canto è stato registrato dal vivo. Non si può fare il playback di un crollo emotivo. Le canzoni non sono sequenze di fantasia: sono verità psicologiche. E anche se la canzone sembra piena di speranza, le luci dicono altro. C’è uno scollamento tra melodia e realtà. Così il musical diventa lo specchio della negazione collettiva.
Famiglia e paura dell’altro
All’inizio del film, la famiglia sembra un rifugio. Ma la paura e la vergogna per ciò che
hanno fatto li ha trasformati in una prigione. Quando arriva la ragazza, porta un dono: onestà
e compassione. È in grado di nominare il proprio rimorso senza vergogna.
La differenza è cruciale: la vergogna è paura di come ci vedono gli altri; il rimorso è un
desiderio profondo di fare meglio.
Il rimorso ha il potere di risvegliare la nostra umanità e far nascere l’amore. Potrebbe trasformare la famiglia da gabbia a nido. Ma nel caso di The End, questa è una storia di avvertimento. È troppo tardi: c’è troppo sangue, troppe ferite non dette. Non riescono ad accoglierla davvero. E così la ragazza non trova un porto sicuro per la sua verità, e il dolore diventa insostenibile da portare da sola. Si arrende a quelle stesse menzogne palliative e canta con la madre. Ma è una menzogna.
La verità è che la nostra capacità di amare si svuota, se mentiamo a noi stessi. Quando manteniamo silenzi dentro alle relazioni — con partner, figli, amici, sconosciuti, rifugiati — perdiamo l’umanità. I legami diventano non più vie di amore o speranza, ma territori minati in cui camminiamo in punta di piedi per non far esplodere i non detti.
Testimoniare l’apocalisse – durante le riprese
Durante le riprese eravamo profondamente consapevoli che stavamo cercando di raccontare
la nostra fine possibile, e il presente reale.
Dobbiamo essere sinceri sulla nostra mortalità, sul fatto che potremmo estinguerci. A quella
consapevolezza dobbiamo rispondere chiedendoci: “Cosa significa vivere bene? Quale
compassione emerge da questa consapevolezza? Dove ci guida, se la ascoltiamo davvero?”
Il film non dice che l’umanità è senza speranza. Dice che abbiamo una scelta, ora. Ma non ci sarà sempre. Per questo abbiamo fatto The End. Finché c’è ancora cielo sopra di noi, c’è ancora una direzione da scegliere.
The End mi è sembrato subito in linea con il suo lavoro sui temi della negazione e dell’autoinganno, anche se questa volta in forma narrativa.”
Durante la lunga attesa prima delle riprese, MacKay ha potuto costruire col regista un dialogo costante: “Abbiamo lavorato per un anno insieme prima del set. Quel tempo ci ha aiutati a capirci, a trovare un linguaggio comune. È stato fondamentale, perché il film richiedeva una precisione assoluta — quasi matematica.”
Joshua Oppenheimer e George MacKay x Biografilm 2025
Tom Quinn— Il pubblico è più di quel che crediamo
Tom Quinn, lo sguardo che scommette sul rischio, produttore e fondatore della casa di distribuzione NEON, è una delle figure più influenti del cinema indipendente americano. Oltre a sostenere Orwell 2+2=5 e The End, Alpha di Julia Ducournau e Together di Michael Shanks presentati al Biografilm 2025, la sua filmografia include titoli come Parasite, Titane, Anatomy of a Fall.
Durante l’intervista a Bologna ha sottolineato l’importanza di “dare spazio a film che rischiano, che rompono le aspettative”. E ha aggiunto: “Il pubblico è molto più curioso e pronto di quanto si pensi. Sta a noi non sottovalutarlo.”
Il suo intervento si è rivelato anche un manifesto per un cinema che osa, che provoca senza sconti. Non a caso, ha ricevuto quest’anno Il Make it Real Award, premio per i professionisti che si sono distinti nel campo della produzione e distribuzione di film documentari.
- Neon è conosciuta per un cinema audace e politicamente risonante, come si bilancia l’autonomia artistica con la domanda del mercato assicurandosi che film dissidenti o provocatori raggiungano il grande pubblico?
“Cerco di pensare il meno possibile al business in realtà, quando mi siedo a guardare un film se sto pensando al suo possibile successo anziché a ciò che il film sta dicendo penso che quel film abbia perso.
Quindi cerco di mettere al primo posto la creatività, il talento che vedo nell’opera e il suo intento, magari la sua valenza politica e culturale. Queste sono le cose che veramente hanno valore.
Il potere del cinema è riuscire a mettere insieme la visione di un autore alla visione di un pubblico in un luogo fisico come il cinema. Quando queste tre cose riescono a stare insieme allora è un film di successo. Questo è ciò in cui credo e quando ti impegni per perseguire questa strada puoi arrivare a farcela, tenendo presente che potrai avere dei film che non avranno un grande impatto. L’importante è essere sempre in grado di poter colpire un’altra palla, tra successi e insuccessi.”
Ho amato la definizione che mi hanno dato qui al Biografilm di “artiere”, fra l’arte e l’artigiano, credo rappresenti la nostra ossessiva ricerca di qualità, che è il nostro tratto distintivo.
C’è un’altra frase che prendo in prestito dalla regista francese Céline Sciamma, lei dice che se un film non è politico non è un’opera d’arte, mi sembra che per avere un impatto culturale di valore un film deve avere sempre un lato politico in parallelo a quello emotivo.
«Neon è una delle realtà più interessanti del cinema mondiale contemporaneo. L'arrivo a Biografilm di ben quattro film della loro scuderia, accompagnati dai rispettivi registi, dona grande prestigio al nostro Festival.»
Massimo Benvegnù, co-direttore artistico di Biografilm
Ritratti locali, un bouquet di voci italiane
Se la sezione internazionale ha messo in scena un cinema che osa rileggere il mondo e sfidare l’apatia, altrettanto hanno fatto alcune voci italiane, capaci di raccontare la realtà con delicatezza e precisione, partendo da contesti locali ma toccando temi universali.
Da Il Pilastro — cronaca partecipata di un quartiere vivo e contraddittorio — a Claudia fa brutti sogni, ritratto intimo e spiazzante di una ferita familiare, il cinema italiano ha trovato al Biografilm nuove forme per raccontarsi e mettersi a nudo.
Il Pilastro — Un quartiere “esemplare”
Il Pilastro è un film nato dentro il quartiere che racconta. Diretto da Roberto Beami e prodotto da Mauro Bartoli, è frutto di un lungo percorso condiviso con abitanti, archivi e istituzioni culturali bolognesi. Una produzione radicata, partecipata, attenta al tempo lungo e alla complessità che è stata premiata Best Film BPER Award per il miglior film di Biografilm Italia.
«Tutto è nato quasi per caso», racconta Bartoli. «Stavo tenendo un corso sui mestieri del cinema alla Cineteca di Bologna. Con gli studenti siamo andati al Pilastro per realizzare un piccolo lavoro documentario. Collaboravamo già con Bruna Gambarelli e Laminarie, che gestiscono il teatro DOM — la cupola al centro del quartiere — ed è lì che ho capito che c’era la possibilità di fare qualcosa di più. Roberto aveva uno sguardo preciso e abbiamo deciso di lavorare insieme.»
La parola chiave, per Beami, è stata ascolto.
«Ci siamo messi in una condizione di vera apertura. Il comitato di quartiere, le persone, la memoria: tutto arrivava in modo spontaneo, come se si attivasse una cascata. Questo da un lato ha rallentato il montaggio, ma ci ha permesso di trovare materiali importantissimi, anche per capire come certe scelte urbanistiche, sociali, culturali siano diventate un’eredità ancora oggi viva.»
Roberto Beami - Regista
Il Pilastro non è solo il soggetto del film, è anche il metodo. Un documentario che parte dal territorio ma parla a tutti: “Per noi è un gesto politico restituire visibilità a chi non ce l’ha.”
«Essere al centro del quartiere, passare il tempo al DOM, incontrare chi vive lì ogni giorno, ci ha permesso di costruire una relazione di fiducia. All’inizio c’era diffidenza, com’è naturale. Ma poi è successo qualcosa: c’è stata risposta. Due proiezioni sold out non sono solo un risultato, sono un gesto di partecipazione.»
Il film racconta un quartiere simbolico, ma non idealizzato.
«Il Pilastro non è un’isola felice», sottolinea Bartoli. «È un rione con contraddizioni, ma dove c’è stata — e c’è ancora — la volontà di cambiare le cose. Persone che propongono modifiche al piano regolatore, che piantano alberi, che creano spazi culturali e sportivi. È un’idea diversa di cittadinanza: non solo diritti e doveri, ma la costruzione attiva di legami sociali.»
Una storia che interroga anche chi guarda.
«Il film non vuole dare risposte, ma far nascere domande: com’è possibile che certe esperienze si siano perse? Perché non partecipiamo più? Forse è il ritmo di vita, forse la sfiducia. Ma questa memoria collettiva non possiamo lasciarla indietro!»
Dal punto di vista produttivo, il progetto ha coinvolto alcune delle istituzioni culturali più rilevanti della città.
«La Cineteca, il teatro, l’orchestra che ha suonato le musiche di Stefano Pilia... È stato un modo per alimentare un’idea di mutuo riconoscimento: non solo raccontare il quartiere, ma far sentire che qualcuno se ne interessa davvero.»
CLAUDIA FA BRUTTI SOGNI — «Questa è la mia storia, e il mio modo di amare» Il coraggio dell’esordio
Sperimentale, onirico, imperfetto e sorprendente: Claudia fa brutti sogni è il progetto di due giovani registi formatisi in un’accademia che a Biografilm hanno trovato il loro debutto, doppiamente confermato con una Menzione speciale TOP DOC e dal Premio DocPoint Helsinki | Biografilm Italia 2025.
“Claudia è una nostra amica, una figura reale che però nel film diventa simbolica, quasi evanescente”, spiegano gli autori Eleonora Sardo e Marco Zenoni.
Il film mescola linguaggi, dalla fiction alla performance visiva, in un racconto che parla di disagio, identità e
frammentazione. “Non volevamo fare un film pulito. Volevamo qualcosa che somigliasse al nostro modo di vedere il mondo.”
Eleonora Sardo e Marco Zenoni
Una piccola produzione indipendente, ma con una voce potente. Claudia fa brutti sogni è un film profondamente personale. Nasce all’interno di un percorso accademico, ma diventa presto qualcosa di più: un atto di riconciliazione, un tentativo di comprensione e guarigione. La regista — anche sceneggiatrice e sorella della protagonista — ha scelto di affrontare una delle esperienze più difficili della sua vita: il rapporto spezzato con Claudia, interrotto anni prima dalla tossicodipendenza.
«Fin dall’inizio ci siamo detti che dovevamo essere onesti. Niente pietismo, niente stereotipi. Volevamo raccontare con lucidità quello che succede in una famiglia quando una persona sta male e tu non riesci ad aiutarla. Volevamo che fosse una storia vera, non una richiesta di compassione.»
Il documentario segue le due sorelle per tre settimane, in una convivenza forzata ma necessaria, fatta di silenzi, cammini condivisi, piccoli gesti, tensioni. Nessun copione, solo realtà:
«Ho provato prima a scrivere una sceneggiatura, ma non era il modo giusto. Solo vivendo accanto a lei, riprendendo quello che accadeva, ho capito cosa volevo dire davvero.»
La macchina da presa non è un filtro, ma una lente che cambia prospettiva:
«Io la vedevo solo come una tossicodipendente, la etichettavo. Girando questo film ho iniziato a vederla di nuovo come una persona. Ho capito che ha un problema, e che io sono parte di quella storia — ma non ne sono la causa. Questo lavoro mi ha fatto vedere tutto in modo più nitido. Un po’, attraverso il film, sono guarita anch’io.»
L’opera richiama una riflessione profonda sull’esposizione pubblica del dolore
«Mi sono sentita in colpa a lungo. Mi chiedevo: che diritto ho io di raccontare questa storia? Come posso mettere in piazza il dolore dei miei genitori? Poi ho capito che questo è il mio modo di amare. E che nonostante il dolore, questo film genera riconoscimento: tutti si rivedono in Claudia. È una storia familiare, e certe ferite appartengono a tutti.»
Aspettando Biografilm 2026...
Dalle visioni internazionali ai ritratti locali, dalle produzioni d’avanguardia ai primi passi nel mondo del cinema: le interviste raccolte durante Biografilm ci restituiscono un festival vivo, fatto di scambi sinceri e di storie che restano.
Nel panorama sempre più ampio dell’industria cinematografica, in un presente affollato di immagini cresce una domanda diversa, di storie che parlino davvero, che pongano domande, che ci mettano in contatto con altre esistenze. Non si tratta di opporsi al cinema mainstream, ma di riscoprire in mezzo a questo flusso continuo, quanto sia ricca, plurale e viva l’esperienza cinematografica quando è anche incontro, dialogo, relazione, perciò, confermandosi uno spazio necessario... anche quest’anno, Biografilm ha saputo essere questo: un punto di incontro tra chi fa cinema, chi lo guarda, e chi lo vive, ecco quindi che non possiamo che fare altro che il conto alla rovescia aspettando la prossima edizione.





.jpg)


%20(1).png)




%20(1)-min.jpeg)





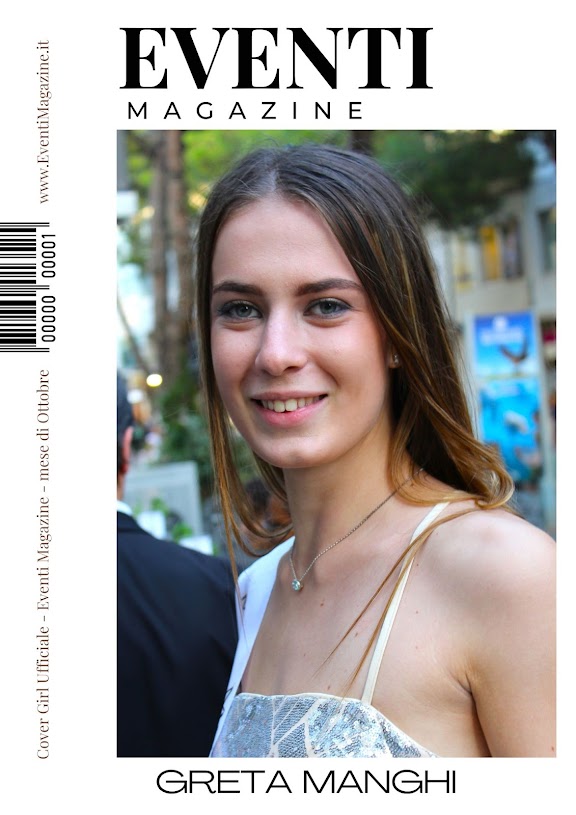


.png)






.JPG)


Commenti
Posta un commento